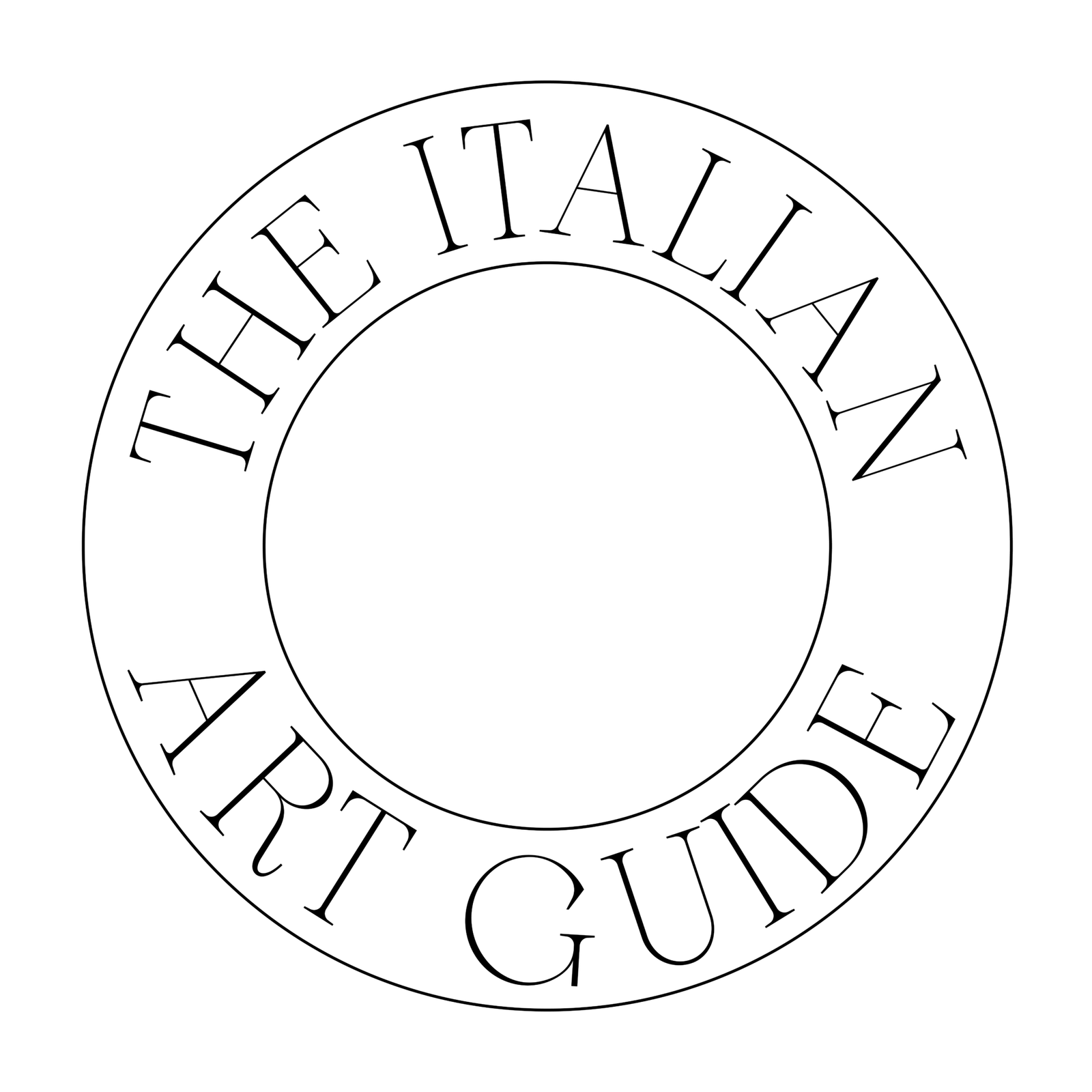ll respiro nascosto delle cose. Omaggio a Hélène







Nella prima sala di Palazzo Oldofredi, l’ambigua astrazione di Stuart Arends sviluppa un dialogo inedito con le imponenti costruzioni monocromatiche in metallo di Julia Mangold, dove lo spettatore è invitato a fare esperienza di luoghi improvvisamente alterati dai suoi interventi. Sulle pareti d’entrata, persino un po’ nascoste, si scoprono due piccole opere su supporto in legno, una con elementi rossi e l’altra grigia. Sono state realizzate a quattro mani da Arends e da Hélène (proprio lei compare nel titolo) che ha lasciato in superficie le proprie impronte in un gioco ironico di condivisione e di responsabilità dove a cadere nella rete è la pittura stessa.
Nella sala centrale del Palazzo affrescata con soggetti ispirati alla Favola di Amore e Psiche di Apuleio s’inserisce l’intervento di Vincenzo Castella che sovrappone, come fossero layers, le grandi fotografie del Martirio e trasporto del corpo decapitato di San Cristoforo di Andrea Mantegna sviluppando un percorso straniante dagli effetti illusionistici accentuato dalla pittura lenticolare di Luigi Carboni con piccoli dipinti in rilievo su marmo bianco e il dittico Lezione bianca dove la monocromia viene annullata da delicati segni di foglie e piante.
Illusioni e allusioni tracciano l’intero percorso della mostra: nella terza sala Gabriele Basilico ci pone di fronte all’architettura dello spazio con fotografie di Roma e Napoli, mentre Emil Lukas lo simula inventando stratificazioni di elementi casuali, tra cui le larve, che vanno incontro a un reale solamente immaginato.
Nel loggiato si trovano i Totem stretti e lunghi di Franco Passalacqua caratterizzati da una pittura modulare che tende verso l’astrazione dando vita a un bosco verticale in relazione con il paesaggio e con gli affreschi fragili ed evanescenti ispirati a Castel Sant’Angelo.
Le suggestive cantine in mattoni con volte a botte sono introdotte da uno spazio antistante dove compaiono il video e le stampe fotografiche di Eelco Brand. Sono animazioni 3D dove il paesaggio ricreato e ibridato non è altro che una proiezione dei nostri stati d’animo.
Le cantine presentano tre interventi distinti: Anna Galtarossa dispone al centro della sala Dungeon Lullaby, un’installazione inedita realizzata con materiali vari dove l’evocazione dolce della ninna-nanna si associa al tema dell’oscurità creando un’intrigante trappola visiva.
Inedito anche l’intervento di Arthur Duff che mette in scena ulteriori inquietudini proponendo per quest’occasione PREDA, un’opera che si compone di quattro proiettori laser destinati a interagire con l’ambiente facendo ruotare le lettere (in questo caso vengono utilizzate le quattro lettere della traduzione inglese di preda, ovvero prey che hanno lo stesso suono di pray, ovvero “pregare”) intorno a un asse immaginario, ciascuna con una propria orbita.
Nel terzo ambiente compare una serie di lavori di Hiroyuki Masuyama dedicata a William Turner. Sono light box di dimensioni differenti dove i dipinti del pittore inglese subiscono un processo di destrutturazione che nasce e si sviluppa attraverso il medium fotografico. Masuyama effettua un montaggio complesso stratificando le immagini e sovrapponendole in un’ibridazione che coinvolge l’opera originale e lo sguardo dell’autore.
La facciata esterna della settecentesca chiesetta sconsacrata di San Rocco è dominata dall’intervento di Herbert Hamak con i suoi classici elementi modulari in resina da cui filtra il blu. Sono opere che cambiano intensità e profondità in base alla luce e al punto di vista di chi guarda, così come avviene per le due colonne a terra in parte sovrapposte nel parco adiacente al Palazzo. Purezza, concentrazione, luce e materia caratterizzano i lavori dell’artista tedesco presente anche all’interno della chiesetta in dialogo con Ivy, la poetica ed evocativa installazione di Jacob Hashimoto con aquiloni di bambù e carta che richiamano l’edera evocata dal titolo. Accanto all’opera, viene collocata una bicicletta ideata da Hashimoto del celebre artigiano veronese Dario Pegoretti, disposta immobile su un piedistallo, come se fosse privata del movimento, creando un evidente contrasto con le forme sospese della natura che si ritrovano anche nei due dipinti.
Torre Pallavicina, con i suoi palazzi storici e una storia che risale all’epoca romana, è diventata dal 2012 sede di importanti mostre d’arte contemporanea. Il primo evento è stato dedicato a Piero Manzoni in occasione dei cinquant’anni dalla morte. Da allora si sono succeduti artisti di generazioni diverse coinvolti ogni anno da rigorosi progetti curatoriali. Sono molti i grandi protagonisti che hanno lasciato il segno a Torre Pallavicina: da Maria Lai a Michelangelo Pistoletto; da Paolo Icaro a Subodh Gupta, da Sergio Lombardo a Alfredo Pirri. Anche la fotografia ha avuto un ruolo significativo coinvolgendo tra gli altri Luigi Ghirri e Francesca Woodman. Ma è soprattutto il contemporaneo ad aver trovato accoglienza con artisti quali Gianni Caravaggio, Jacopo Benassi, Francesco Arena, Maurizio Donzelli, Maria Elisabetta Novello, Matteo Fato, Paolo Grassino, Simone Berti e Fabrizio Prevedello.