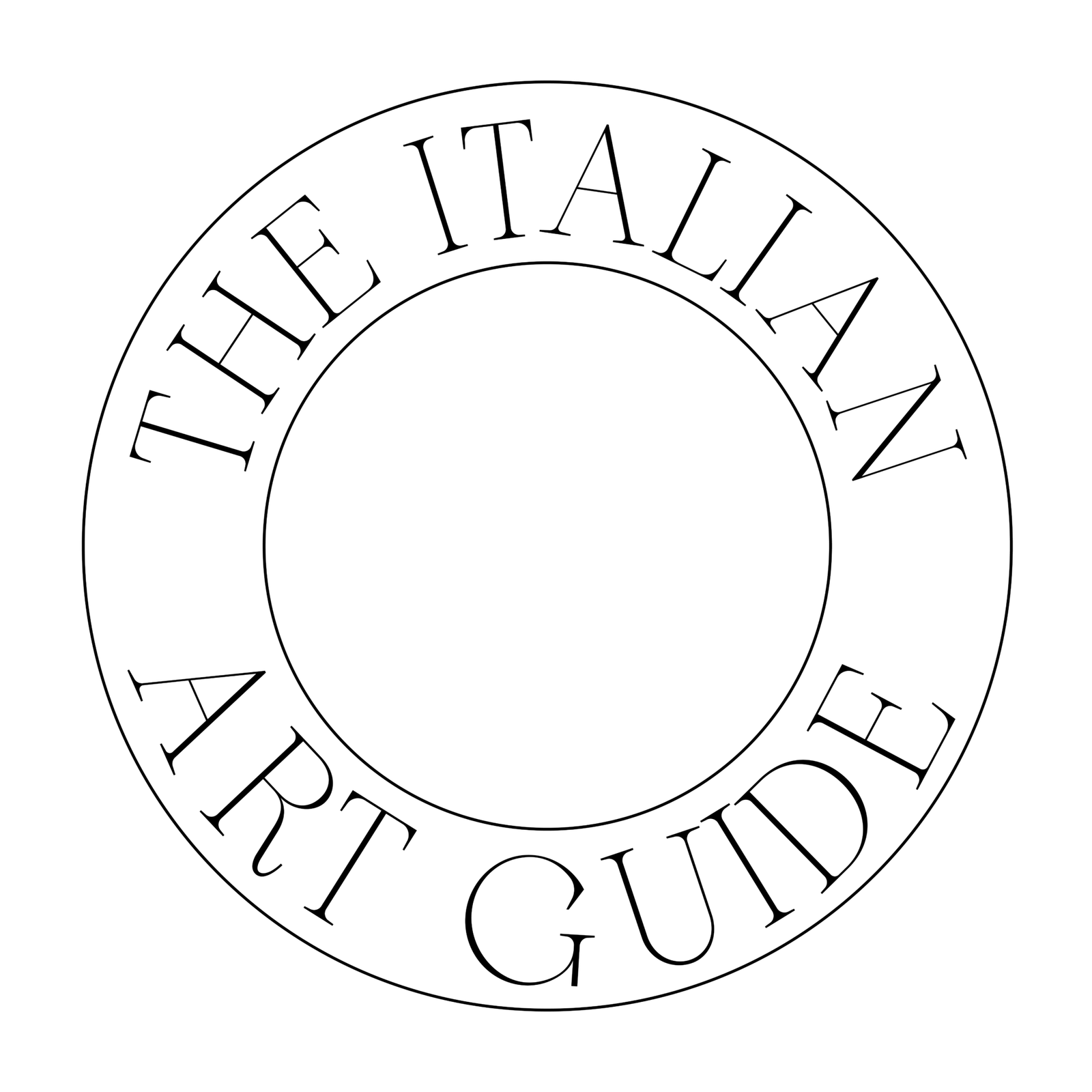5 mostre per parlare di femminismo. In Italia a settembre
Di Marianna Reggiani
01.09.2025
Click here to read this article in English
Fine estate, tempo di bilanci. Settembre è spietato nel ricordarci che il momento di procrastinare deve finire adesso, per non rischiare di rimandare tutto a gennaio. Procrastinare significa scoraggiare i cambiamenti e, quando i cambiamenti sono urgenti, diventa un atto imperdonabile.
Non dovrebbe esserci bisogno di spiegare perché, in un Paese in cui la percentuale di artiste esposte nei musei oscilla tra il 10% e il 15%, in cui “più si sale di grado, minore è il numero di artiste presenti”* – accademie, aste, gallerie, istituzioni pubbliche e private, fino ad arrivare alle Biennale di Venezia –, cambiare non è procrastinabile.
E mentre ci chiediamo perché nei titoli di giornale si senta ancora il bisogno di scrivere “mostra al femminile” – sottintendendo che lo standard, quello che invece non ha bisogno di specifiche, è maschile –, ci rendiamo conto che il problema è uno sguardo ancora profondamente sbagliato. Uno sguardo giusto scriverebbe i nomi e i cognomi delle artiste in prima pagina, si soffermerebbe sui loro talenti e percorsi invece che sui loro vissuti personali. Uno sguardo giusto entrerebbe nel merito delle loro ricerche, invece che restare sempre comodamente in superficie.
Ecco cinque mostre da visitare a settembre per cambiare sguardo, per uscire da quel ghetto “al femminile” che è sempre stato troppo stretto.
Light and fight – Luce e lotta nelle opere di Zehra Doğan, Fondazione MACC di Calasetta, Sardegna (fino al 30 settembre)

Fondazione MACC, Calasetta, Sardegna. Zehra Dogan. Light and fight, exhibition view, ph Margherita Villani, courtesy dell’artista;
Tutto è simbolico nella mostra ospitata dalla Fondazione MACC di Calasetta, nel sud di una Sardegna che si specchia nel Mediterraneo e che saluta Africa e Europa ogni mattina.
L’artista, giornalista e attivista curda dissidente del regime di Erdogan porta la sua voce ancora memore – come sempre lo sarà – dell’esperienza del carcere del 2015.
In mostra, a raccontare la clandestinità della sua arte ci sono le opere realizzate nella prigione numero 5 di Diyarbakir, Turchia orientale. Lenzuola, caffè, cenere di sigaretta, sangue mestruale, capelli, piume: la sua arte illegale vive nei materiali di scarto recuperati ai margini di una sopravvivenza ostinata, un’arte disobbediente che denuncia le condizioni femminili nelle carceri e la censura subita.
Il grido di Zehra Doğan dialoga con la tradizione tessile sarda – antica, lenta, meditativa – attraverso l’utilizzo dei tappeti come supporti narrativi. Ogni tappeto ha così un corpo, una voce e uno sguardo per raccontare la propria storia.
Euforia. Tomaso Binga, Museo Madre, Napoli (fino al 15 settembre)

L’ha detto Carla Lonzi, che “il femminismo è stata la mia festa” (Taci, anzi parla. Diario di una femminista, 1978, Rivolta Femminile), e così lo ripete, a modo suo, Tomaso Binga. Nella sua più ampia retrospettiva museale, che ripercorre quarant’anni della sua pratica attraverso circa centoventi opere, l’artista sceglie, insieme alla curatrice e direttrice del Museo Madre Eva Fabbris, un titolo che è già un manifesto. La parola “Euforia” contiene tutte le vocali, “foneticamente universale ed estroversa”**, rappresentativa della complessità e dell’esuberanza che, per sua natura, il linguaggio possiede. Una mostra che è festa e celebrazione, dunque, tra poesie visive, installazioni, collage, documenti d’archivio e performance; una polifonia che canta con gioia e cuore pieno la vitalità del linguaggio che può liberare, criticare, dissacrare, costruire e ridefinire.
Rebecca Horn, Cutting Through the Past, Castello di Rivoli, Torino (fino al 21 settembre)

Prima retrospettiva dedicata all’artista in un museo italiano, la mostra curata da Marcella Beccaria ripercorre la carriera di Horn attraverso trentacinque opere, tra installazioni, sculture, video, film e disegni, dagli anni Sessanta che ne vedono gli esordi fino ai lavori più recenti.
Maestra di autodeterminazione, Horn è riuscita a maneggiare i grandi temi della modernità – la macchina, il corpo, il potere – attraverso creazioni uniche, imponenti, fuori dal tempo e circondate da un’aura immortale. Affrancando il corpo femminile dal peso della maternità e della sensualità, Horn lo ha reso macchina rumorosa, minacciosa, inquietante, libera di raccontare bruttezza e disturbo: un processo di risignificazione del corpo di donna per liberarlo dall’immobilità.
Con un titolo che fa riferimento all’installazione del 1993, parte della collezione permanente del Castello, Cutting Through the Past è la prima grande esposizione dalla recente scomparsa dell’artista, morta il 6 settembre 2024 dopo ottant’anni di passi meccanici su questa terra.
Tina Modotti. Donna, fotografa, militante. Una vita tra due mondi, Museo di Roma in Trastevere (fino al 21 settembre)

Da San Francisco al Messico, dalla storia con Edward Weston all’amicizia con Frida Kahlo, fino alla militanza nel Partito Comunista Messicano e l’esilio a Berlino: la mostra racconta la vita e l’attivismo politico dell’artista italo-americana che, riscoperta postuma, viene oggi ritenuta pioniera della fotografia sociale. I suoi scatti ci parlano della realtà messicana, della rivoluzione, della partecipazione politica che ha animato il suo fare artistico sin dall’esordio. Allontanandosi sempre più dallo stile pittorico, le sue opere raggiungono un rigore compositivo frutto di uno sguardo fermo e di una sensibilità pura e rispettosa.
Sessanta tra fotografie, lettere, testi, documenti e articoli ci dicono la complessità di una donna che ha vissuto e raccontato tutto in prima persona singolare, senza mai lasciarsi definire. Al punto che anche la sua morte improvvisa e sospetta, avvenuta nel 1942 all’interno di un taxi, si dice per infarto, rimane un mistero ancora irrisolto.
Padiglione Svizzera – Biennale Architettura, Giardini, Venezia (fino al 23 novembre)


Lisbeth Sachs, Kunsthalle per la Mostra Svizzera per il Lavoro Femminile (SAFFA), Zurigo 1958, courtesy La Biennale (sinistra); Padiglione Svizzera, Biennale Architettura 2025, Venezia, courtesy La Biennale (destra);
Quattro giovani architette – Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins e Myriam Uzor – insieme all’artista Axelle Stiefel si domandano come sarebbe stato il Padiglione Svizzero nei Giardini della Biennale di Venezia se, invece di Bruno Giacometti, l’avesse progettato Lisbeth Sachs, tra le prime architette svizzere. La forma finale sarà determinata dall’architetta sul cantiere (Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt) è infatti il titolo della mostra, citando un appunto annotato da Sachs sul progetto della Kunsthalle per la seconda Mostra Svizzera per il Lavoro Femminile (SAFFA), tenutasi a Zurigo nel 1958. Promossa da trenta organizzazioni femminili, la SAFFA aveva il preciso intento di fare luce sulla precarietà delle professioniste negli anni del Dopoguerra. È proprio quel progetto a rivivere quest’anno a Venezia, con un allestimento che, mentre dialoga con Bruno Giacometti, punta i riflettori sul vuoto storico di architette nei Giardini della Biennale, dove nessuna donna ha infatti mai progettato un padiglione nazionale.
*Francesca Guerisoli, Il Sole 24 Ore, novembre 2018 (link)
**Euforia. Tomaso Binga, Museo Madre, Napoli, communicato stampa;