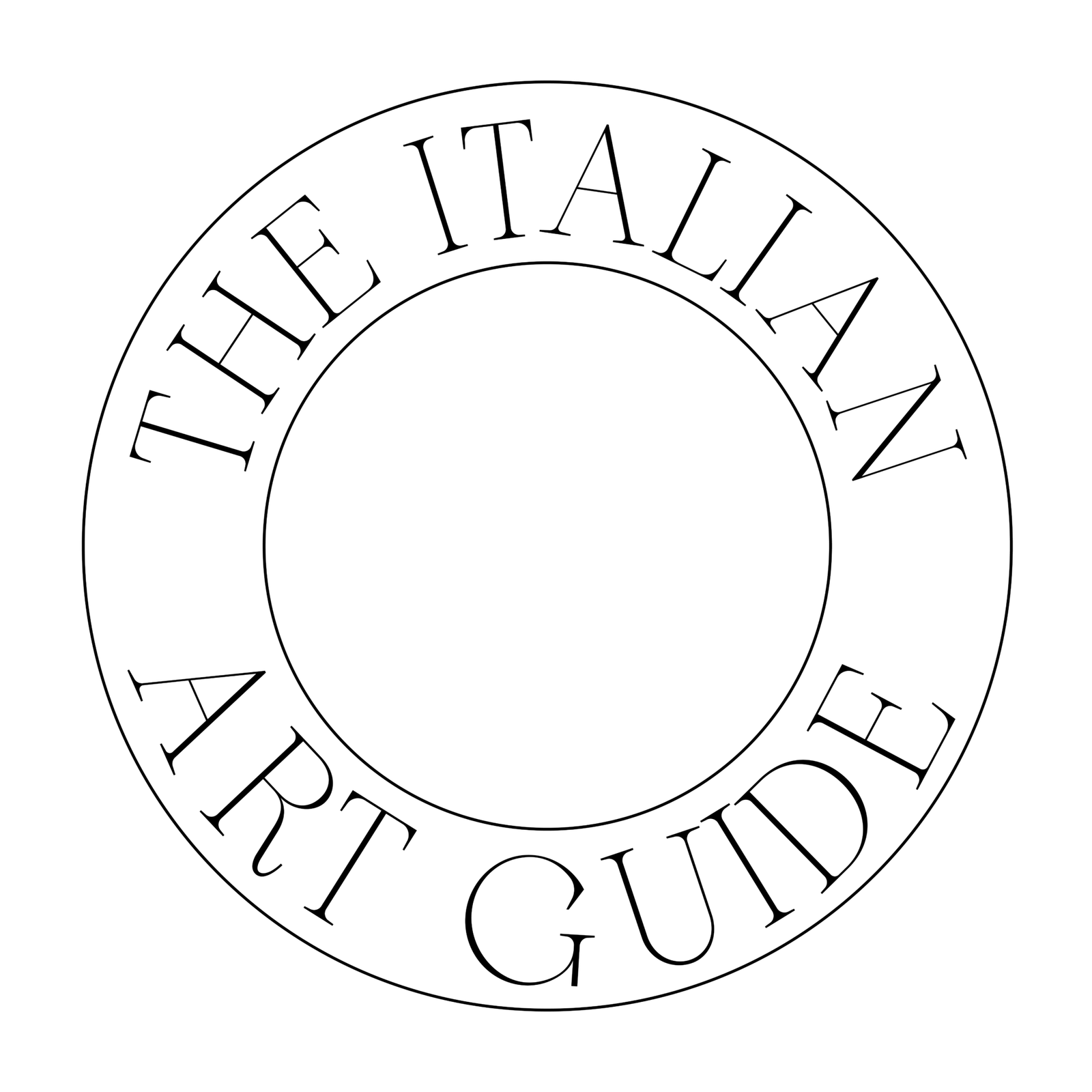Tu che guardi non sei “altro”, così come non lo sono loro, che ti piaccia o no.
click here to read this article in English
PREMIO PAUL THOREL: OSSERVATORIO SULLA FOTOGRAFIA DIGITALE IN ITALIA. INTERVISTA A LINA PALLOTTA.
Lina Pallotta, tra i vincitori della prima edizione del Premio Paul Thorel, ha partecipato alla residenza artistica presso Gallerie d’Italia di Napoli, conclusasi con la mostra L’undicesima casa e con la pubblicazione del libro d’artista Voce ‘e stommache.
L’intervista di Marianna Reggiani

Sta sporta alla finestra, intenta a scuotere un lenzuolo che le copre il volto. Attorno a lei, le pareti dell’edificio lasciano intravedere crepe e tubature malconce, sgraziata cornice del lenzuolo candido sospeso nell’aria, piccola e pura nuvola bianca affacciata sulle strade del centro di Napoli. È Loredana Rossi, fondatrice e vicepresidente di ATN (Associazione Trans Napoli), organizzazione non governativa nata nel 2007 per tutelare i diritti e la dignità delle persone trans.
Lina Pallotta — fotografa campana che da sempre ha fatto della rappresentazione degli emarginati e degli esclusi la propria bandiera — dal 2011 collabora con Loredana fotografando gli ambienti abitati dalla comunità, portando avanti una narrazione che prende le distanze dai racconti stereotipati dei mass media. Al contrario, le sue opere mostrano la dimensione privata, nascosta e intima dei soggetti che ritrae, quella dimensione che distingue una persona da un’esca da clickbait.
Il libro d’artista Voce ‘e stommache (Nero Editions, novembre 2024) è il frutto della residenza presso la Fondazione Paul Thorel di Napoli, cui Pallotta ha preso parte in quanto vincitrice (insieme al collettivo Clusterduck e Jim C. Nedd) della prima edizione del Premio Paul Thorel, osservatorio sulla scena creativa italiana focalizzato sull’immagine digitale.
Tra settembre e ottobre 2023 Pallotta ha fotografato senza sosta le persone che ha incontrato, raccontando storie autentiche di una comunità che lotta e resiste quotidianamente senza che nessuno se ne accorga. Fotografa in strada, nelle case, o ancora nello studio dell’artista Paul Thorel (1956-2020), messo a disposizione dalla Fondazione.
L’undicesima casa (9 marzo – 5 maggio 2024, Gallerie d’Italia, Napoli) è la mostra che ha esposto i lavori dei tre artisti vincitori. L’installazione di Pallotta — un grande specchio orizzontale che fa da supporto alle fotografie — permette allo spettatore di vedersi e riconoscersi mentre cammina, scoprendosi parte integrante di un mondo da sempre raccontato come lontano e diverso, complesso e difficile, talvolta ridicolo e degradante.
Con l’artista abbiamo parlato di contronarrazioni, racconti alternativi e nuove rappresentazioni.
Questa è stata la prima volta in cui hai utilizzato il colore per un tuo progetto. Come è andata?
Negli anni Novanta utilizzavo molto il colore per gli editoriali, per i lavori da fotogiornalista, quindi per me è sempre stato connesso al lavoro, a ciò che mi chiedevano di fotografare. Non l’ho mai usato per i miei progetti personali.
In questo caso invece, dal momento che la Fondazione si occupa di diffondere la fotografia digitale – di cui Paul Thorel è stato uno dei pionieri –, ho dovuto per forza avere a che fare con il colore.
Inoltre, durante la residenza ho avuto a disposizione lo studio di Paul Thorel, e anche questo non rientra esattamente nel mio campo: io ho sempre lavorato con pellicola in bianco e nero utilizzando la luce naturale, e in situazioni poco illuminate. Questo dà vita a superfici granulose e a volte fuori fuoco, mentre il digitale genera immagini omogenee, con una superficie liscia, molto a fuoco e ben scandita. Questo mi ha sorpreso più del colore, ero abbastanza timorosa.
All’inizio è stato difficile riconoscermi negli scatti. Ho provato un forte senso di disorientamento, vedevo delle cose che non riuscivo a interiorizzare. Poi ho deciso di utilizzare il trasferimento dal colore al bianco e nero, e così ho iniziato a ritrovarmi, a vedere me stessa nelle fotografie. Mi sono lentamente liberata da alcuni paraventi che la mia storia personale mi mette sempre sul cammino.
Ho lasciato a colori tutti i ritratti realizzati in studio, insieme a tutte le fotografie di eventi pubblici. Così il colore ha assunto una sua specificità.

Sfogliando le fotografie, si percepisce la forte coralità del progetto, l’intento di coinvolgere più soggetti possibile. Quanto influisce il dialogo che immagino tu abbia avuto con queste persone sulla tua fotografia? Quanto scambio umano c’è?
Ce n’è tanto. Sono partita da Loredana Rossi, che ho conosciuto tramite Porpora (Marcasciano ndr) e che avevo già fotografato in passato. Grazie a lei e a Mario Di Martino ho conosciuto le altre persone che ho ritratto durante la residenza. Tutte loro avevano già familiarità con il mio lavoro. Questa sorta di avvicinamento mi ha permesso di “saltare” una serie di passaggi, rendendo tutto più facile.
Ho chiesto di poter fotografare in situazioni non costruite, come avevo fatto per il progetto Porpora (Nero Editions 2023, ndr), e loro me l’hanno concesso. Dopo una serata passata insieme per me era facile trovare i momenti che cercavo.
Le difficoltà ci sono state quando Loredana è uscita sulla Domiziana a fare l’unità di strada e a parlare con le sex workers. In quei casi non potevo fotografare, soltanto una persona mi ha concesso di farlo.

Il progetto Porpora è durato trent’anni, mentre questo si è concentrato tutto in un solo mese. In che modo il tempo che hai a disposizione influisce sul tuo lavoro?
Il progetto ha richiesto una full immersion: ogni mattina appena mi svegliavo andavo da Loredana o dagli altri. È stato un ritmo che da un lato mi ha stressata molto e dall’altro mi ha fatto concentrare, come una lama a doppio taglio. Avevo questo costante pensiero di dover fare subito, di dovermi sbrigare.
Dopo la fine della residenza sono tornata a scattare a Napoli due volte, in due situazioni specifiche: in occasione del Transgender Day of Rememberance (foto 4), e ancora in occasione di un evento natalizio, la Tombola Scostumata, il 20 dicembre (foto 5).


In tutto questo Napoli che ruolo ha avuto?
Sicuramente il fatto di conoscere Loredana, che è napoletana, ha avuto una sua importanza, come anche l’attitudine stessa delle persone napoletane, che sono tendenzialmente più accoglienti. Ti fanno sentire più “comoda”, anche nel fotografare. Inoltre il caos della città mi ha messo in una condizione di flusso maggiore.
Il titolo del libro è una frase in napoletano che definisce alcune modalità espressive come “la voce dello stomaco”, qualcosa di profondamente viscerale e radicato dentro di noi. Da dove proviene?
Il titolo me l’ha dato Loredana. Un giorno mi ha detto: “Le tue foto sono come ‘a voce ‘e stommache”. Io le ho chiesto “Ma che vuol dire?” … Sai quando una cosa te la senti in pancia? L’ho guardata e le ho detto “Loredana mi hai trovato il titolo”.
In quale parte della tua fotografia risiede questa visceralità?
Scatto rispondendo a uno stimolo momentaneo. Magari posso scegliere la situazione ma il momento dello scatto è sempre una risposta immediata e istintiva, non c’è preparazione, sono sempre molto sfuggenti.
Nell’installazione realizzata a conclusione della residenza, lo specchio può essere interpretato come un invito rivolto al pubblico a prendere parte al dibattito?
Sì ma non solo… Se guardi le opere guardi te stessa, perché ci sono dei vuoti tra una foto e l’altra. Quindi la comunità è comunque intorno a te, ci sei già dentro, anche se la comunità non la conosci. Puoi mettere tutte le distanze che vuoi, ma ne siamo tutti parte.
A un certo punto ho dovuto concettualizzare la scelta delle foto da includere, non volevo costruire qualcosa di lineare perché sentivo che c’era ancora tanto che non avevo esplorato per mancanza di tempo e mi sembrava di aver toccato in maniera frammentaria tante cose. Non avevo la coscienza per fare una selezione radicale, e questo in un certo senso mi attirava. Quindi a un certo punto mi sono domandata come tenere tutto insieme. Lo specchio è diventato l’aggregazione possibile per i frammenti. Ancora oggi, le persone mettono le foto sullo specchio in camera, senza alcuna connessione. È lo specchio stesso a creare il legame.
Tu che guardi non sei “altro”, così come non lo sono loro, che ti piaccia o no.

Il tuo modo di rappresentare la comunità si propone in modo molto esplicito l’impegno di uscire dalle rappresentazioni stereotipate e massmediatiche. Negli anni, durante il tuo percorso artistico, sono cambiate le modalità con cui persegui questo obiettivo?
Le persone più giovani che ho fotografato hanno scelto autonomamente come farsi fotografare, l’hanno scelto come espressione di sé. Questo mi ha fatto capire che è cambiato tanto: anni fa quel modo di rappresentarsi era legato ai club notturni e alla strada. Adesso le persone — anche molto giovani — lo vivono come espressione identitaria ma anche di libertà: “Io sono così, mi vesto glamour non perché vado a battere ma perché è un mio desiderio”. Mi è sembrato di dover dare voce anche a questo aspetto.
Quindi il tuo cambiamento è stato dettato dal cambiamento delle persone che hai fotografato?
Dei tempi e delle persone, sì.
In uno spettro tra la fotografia di documentazione e ritratti di persone a cui vuoi bene, questo progetto dove si colloca?
L’approccio documentario rimane più o meno sempre, nel senso che mi piace immergermi in quello che succede intorno a me. Ma il progetto non ha il rigore che dovrebbe avere un effettivo lavoro documentario, che implica un’attinenza anche più lineare. In questo lavoro sicuramente ci sono degli scatti che rappresentano delle specificità, delle situazioni reali che sono accadute, ma che complessivamente consentono una lettura molto più libera rispetto alla documentazione. Questa presuppone un occhio più oggettivo, mentre come sempre qui di oggettività ce n’è poca. Se devo definirlo, direi che è un lavoro di documentazione frammentaria e decisamente personale.
È stato complicato trasferire la sequenza di immagini dall’installazione alla pagina cartacea?
La difficoltà maggiore è stata quella di riuscire a dare alla pagina la frantumazione che c’era sullo specchio. Su questo aspetto forse ho avuto un po’ di ripensamenti.
Se tu guardi la sequenza delle foto c’è sempre una sorta di un conflitto, la linea narrativa è completamente frantumata. Assemblare lo specchio è stato un po’ come fare un puzzle, l’ho cambiato tante volte. A un certo punto ho stampato un mockup dello specchio in cartone (3 x 2 m) e l’ho portato a Roma, e questo mi ha permesso di poterci lavorare anche a distanza. Da lì ho apportato parecchie modifiche, fino all’ultimo.
C’è qualcosa che vorresti aggiungere, che io ho mancato di chiederti?
Vorrei solo enfatizzare la collaborazione della comunità, perché se loro fossero stati meno disponibili sarebbe stato più complicato. Le persone hanno una vita, quindi un mese sembra tanto ma è pochissimo. Li ho sentiti vicini e pieni di supporto.
Intervista di Marianna Reggiani