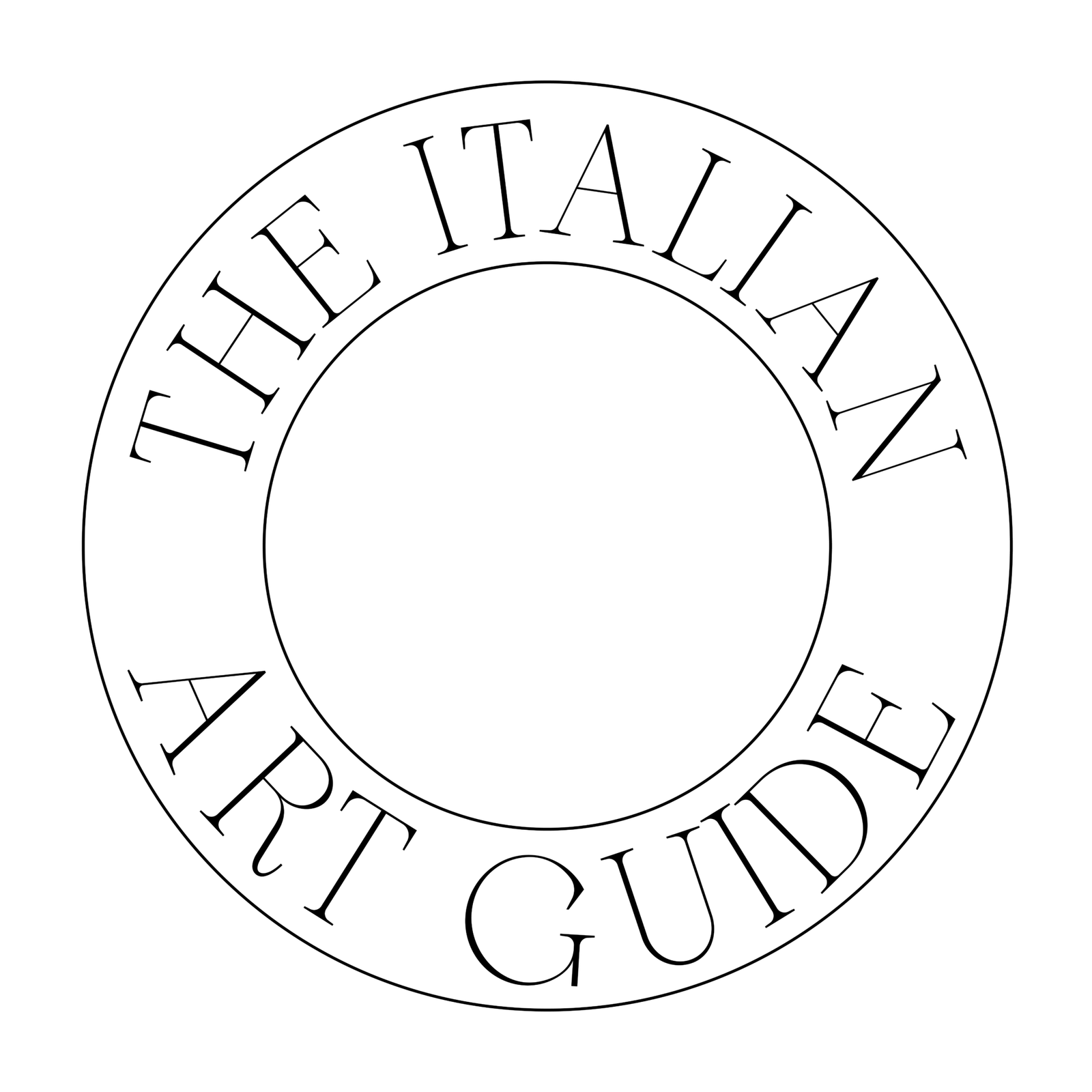3 mostre da vedere a novembre
La nostra guida alle mostre in Italia
Di Marianna Reggiani
04.11.2025
Click here to read this article in English
Nel mese di Artissima e di Art Basel Paris, con un sistema che ruota attorno a opening, previews e vernissage luccicanti, noi consigliamo tre mostre da visitare con la calma di chi all’arte contemporanea chiede qualcosa di meno vendibile: comprensione, onestà, pazienza.
Che forse a volte correre senza mai fermarsi non porta a niente, e lucidare con ossessione le vetrine nel tentativo di raggiungere un’apparente perfezione non renderà l’esperienza più completa: al contrario rischia di restare una delle tante azioni automatizzate che distolgono l’attenzione da ciò che è davvero importante. Ce l’ha ricordato in modo perfetto e senza sbavature il duo scandinavo Elmgreen & Dragset: la loro stanca gallerista addormentata dietro la vetrina di Massimo de Carlo a Parigi ha fatto il giro del mondo, unica vera star di questa art week francese.
Specchio della reale — anzi, iperreale — condizione di tanti professionisti del settore dell’arte, l’installazione October 2025 ci interroga sulla possibilità di finire così anche noi, addormentati su un tavolo mentre il mondo fuori ci fotografa per poi passare oltre. Ci interroga, in sostanza, sulla bontà di un sistema che schiaccia chi rallenta e premia chi sovrasta.
Le tre mostre selezionate raccontano le storie di chi il sistema l’ha più volte messo in discussione, ristabilendo priorità e desideri, obiettivi e motivazioni.
Betty Danon. Io e gli altri – Fondazione Cosso, Pinerolo (fino all’8 dicembre)

Castello di Miradolo, Betty Danon. Io & gli Altri, installation view. ph Paolo Mantovan
Beki Aluf sceglie presto di chiamarsi Betty Danon, tradendo sin da subito la sua fede viscerale nella forza della parola. “Betty”, perché a quel nome di battesimo che la legava alla natale Turchia ha preferito un suono che raccontasse l’ambiente filoamericano in cui è cresciuta; “Danon”, perché neanche lei è sfuggita all’usanza di prendere il nome dell’uomo che ha sposato, prima di trasferirsi con lui a Milano non ancora trentenne nel 1956.
La pratica artistica di Danon è ripercorsa per la prima volta nella sua interezza con la mostra presso la Fondazione Cosso, che racconta tutto l’eclettismo di una figura che ci ha messo poco a capire cosa voleva dai grandi circuiti dell’arte: starne alla larga. Presto segnata dall’incontro con la psicologia junghiana fondata sul vocabolario essenziale di cerchio e quadrato, che Danon traduce in personalissime scritture visive, negli anni Ottanta si rifugia in un universo più intimo e privato: diviene così pioniera della Mail Art in Italia, dove i primi esperimenti del gruppo Fluxus non erano ancora arrivati.
La mostra Io & gli Altri si appropria infatti del titolo dell’opera del 1979, che consacra Betty Danon come portavoce di un sentire collettivo: duecento cartoline postali pentagrammate, sulle quali più artisti — Tomaso Binga, Maria Lai, Mirella Bentivoglio, Emilio Isgrò, Sol LeWitt, Nam June Paik, tra gli altri — hanno operato un proprio intervento, raccontano la vitalità e la poesia insita in una forma d’arte che trae gioia dallo scambio e che non si impantana nella sterile autocelebrazione.
La coralità dell’opera è dunque specchio di una generazione di artisti che sempre più parla di relazioni, rapporti, segni e scritture intime, in un progressivo allontanamento dalle narrazioni tradizionali.
E così quella ricerca che era partita come un viaggio in solitaria, che si era nutrita di quello stesso isolamento, sfocia in un’opera polifonica, che è una festa, un banchetto, un gioioso concerto a più voci.
Lee Miller. Opere 1930-1955 – CAMERA, Torino (fino al 1 febbraio 2026)

La mostra presso Camera chiude un anno in cui di Lee Miller si è parlato tanto — forse per l’uscita del film con Kate Winslet, forse perché certe figure maltrattate dalla storia dell’arte prima o poi tornano a chiedere il conto. Ultima tappa, ultimo racconto autorevole — curato da Walter Guadagnini — di un’artista che, imprigionata per decenni in definizioni rigide e riduttive, si vede ora finalmente restituire la complessità che le appartiene.
La parabola della sua vita, da giovanissima fotomodella a fotoreporter di guerra, è inestricabilmente legata alla collaborazione con Vogue: se a diciannove anni ne abita le pagine grazie al suo fascino straordinario, a trent’anni le riempie con gli scatti realizzati al seguito dell’esercito americano durante il secondo conflitto mondiale, documentando gli ammassi di cadaveri, i campi di sterminio, i suicidi dei gendarmi nazisti alla vigilia della Liberazione. Il prezzo di quella libertà lo paga con la salute mentale, compromessa per sempre dalla depressione e da un disturbo post-traumatico.
Per quanto l’esperienza della guerra sia stata caratterizzante per Miller, la mostra non tace le mille vite vissute nonostante tutto — artista e attrice Surrealista, amica fidata di Max Ernst e Leonora Carrington, amante di Man Ray, esploratrice innamorata dell’Egitto. Eppure, delle sette sale organizzate in nuclei tematici, ben tre sono dedicate alla guerra. Risulta dunque chiaro come ogni tentativo di separare Lee Miller da quell’esperienza traumatica e viscerale sia in realtà un’operazione di mistificazione: è lì che Miller ha fotografato con più onestà, limpidezza e coscienza, comprendendo che in quello strazio non c’era posto per il lirismo che le era appartenuto durante la fase surrealista.
La mostra presso Camera cerca dunque di restituire lo spessore di una figura che a lungo è stata oggetto di letture inesatte, parziali, diminutive. Per far uscire Miller dalla prigione di “musa”, per rendere giustizia alla sua esuberanza creativa e alla fermezza della sua fotografia, Camera espone circa 160 scatti, molti dei quali inediti e provenienti dai Lee Miller Archives.
Claire Fontaine. Casa Fontana – Francesco Pantaleone Gallery, Palermo (fino al 13 dicembre)

Claire Fontaine, Rosso Mediterraneo, 2025, digital print on archival paper. ph Fausto Brugantino, courtesy Francesco Pantaleone Palermo.
Dalle tavole imbandite poco prima di Natale ai sacchi di farina bucati nelle zone di guerra, oggi più che mai il cibo si fa simbolo crudele di benessere o malattia, ricchezza o povertà, privilegio o condizione marginale.
Per una società ormai disabituata alla lentezza e imprigionata in logiche di performance, la riflessione proposta da Claire Fontaine a Palermo risulta scomoda e poco accattivante: cosa rappresenta davvero il cibo che ingeriamo?
Arma in zone di guerra, esca per turisti nelle grandi città, fonte di profitto all’interno di strutture lesive della salute del consumatore, il cibo diventa qui un mezzo per riflettere sulle storture della società che abitiamo, sulle perversioni che la muovono.
Il cibo pronto è come un contenuto social: velocissimo, soddisfacente, gradevole alla vista. Is it a cake? presenta il readymade di Duchamp Fontana — emblema del “già pronto”, facile da confezionare, vendere, proporre — sotto forma di torta — un cibo bello, che stuzzica il palato ma allo stesso tempo vuole essere mostrato nella sua intatta perfezione estetica. Che fai, lo mangi o lo fotografi? L’ambiguità crea il corto circuito.
Il progetto Casa Fontana punta dunque a questo, a comprendere “quanto la ‘Casa’ sia in pericolo”, quanto la teca di vetro in cui abbiamo deciso di rinchiuderci, credendoci al sicuro da malattie, carestie e povertà, sia in realtà una gabbia sotto forma di luccicante soprammobile, perchè se vai a vedere bene quella torta contiene probabilmente ingredienti andati a male.
Che il sistema sia rotto, che i suoi meccanismi non sostengano più il peso delle diseguaglianze e degli scenari disturbanti sempre più evidenti, è una consapevolezza che ci imporrebbe di spezzare la catena e mettere in crisi tutto. La “follia contemporanea” sta arrivando al capolinea: verità troppo scomoda che come un vino inacidito ci va di traverso e che, come il cibo scaduto, non riusciamo a digerire.