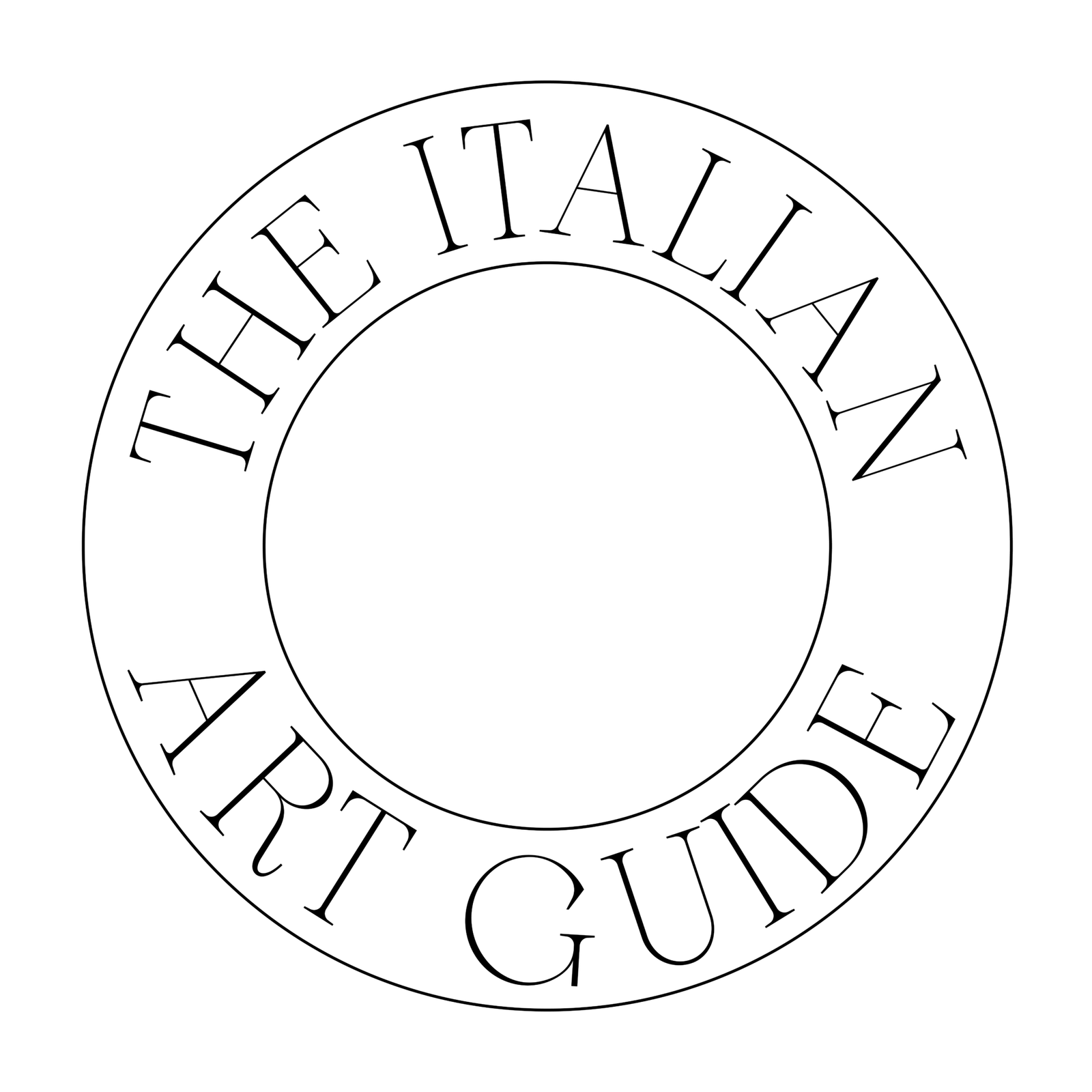Fantastica ma non troppo (in italiano)
di Dobroslawa Nowak
24.12.2025
Click here to read the English version
Fantastica affronta il primo quarto del ventunesimo secolo nell’arte italiana come un insieme di prospettive plurali piuttosto che come una narrazione lineare. Le opere di cinquantatré artisti, nati tra gli anni ’60 e la fine degli anni ’90, sono organizzate lungo cinque percorsi curatoriali sviluppati da Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone, seguendo la visione del critico d’arte Luca Beatrice, che ha concepito la mostra prima della sua scomparsa, avvenuta all’inizio di quest’anno.
La questione più interessante sollevata da Fantastica non riguarda la qualità della mostra o la selezione di artisti e aree tematiche—queste, pur essendo particolari e attentamente scelte, risultano comunque ben note in relazione agli ultimi decenni di curatela istituzionale. La mostra è notevolmente ben curata. Ciò che risulta davvero stimolante, piuttosto, è un dubbio di matrice heideggeriana: possiamo comprendere le condizioni della conoscenza non come strumenti neutrali, ma come forme di intreccio esistenziale con il mondo, con soggetti e osservatori situati nel presente? In tal senso, Fantastica inquadra l’arte come esperienza situata piuttosto che osservazione distaccata, ponendo la questione di come l’essere-nel-mondo renda possibile la conoscenza.
Per questo motivo, al di là della mera intellettualizzazione o del giudizio valutativo su artisti, opere e scelte curatoriali, la questione urgente diventa: fino a che punto gli artisti—e i curatori che ne plasmano la presentazione—costituiscono uno spazio in cui possiamo percepire noi stessi, riconoscendo la nostra presenza e il nostro intreccio con il mondo che essi costruiscono?

Dai passi iniziali nell’ampio atrio del Palazzo delle Esposizioni, prima di incontrare l’opera che apre la mostra—l’imponente installazione post-apocalittica secondary forest (2024) di Giulia Cenci, inclusa nella sezione Memoria piena. Una stanza solo per sé curata da Francesco Bonami—sentiamo un forte e abrasivo stridio. Il suono proviene dalle mostruose braccia meccaniche di una benna azionata idraulicamente, che si muove in modo imprevedibile e riecheggia nella vasta sala a sinistra dell’ingresso. Si tratta di Hunger (2002) di Arcangelo Sassolino, il cui rumore inquietante persiste come un afterimage uditivo, accompagnandoci per quasi tutta la mostra.
Per attenuare questa tensione e ricordarci che siamo ancora all’interno di un museo—uno spazio di indagine e provocazione, non di puro terrore—il grande Welcome (2025) di Luca Bertolo appare come scagliato con disinvoltura all’ingresso. Ironico aggiornamento contemporaneo dei mosaici pavimentali antichi, le sue tessere compongono la parola titolo dell’opera, oggi comunemente stampata sui nostri zerbini.

Sulle orme dell’Exposition Internationale du Surréalisme del 1938, la sezione Senza titolo curata da Francesco Stocchi, che include Hunger, Welcome e altre opere di un gruppo di nove artisti, funziona come un laboratorio. Piuttosto che illustrare un concetto, Senza titolo apre uno spazio per l’azione creativa collettiva. Gli artisti sono coinvolti in ogni fase—dalla concezione al design dello spazio—reclamando l’autorialità non solo delle opere, ma anche delle condizioni in cui vengono presentate.
Da un lato, è da tempo che le opere non sono più semplici oggetti da guardare. Dall’altro, questa evoluzione è stata graduale—da opere interattive che invitano a una partecipazione spesso ignorata, a esperienze così elementari e trasparenti da diventare poco interessanti, fino a installazioni così meticolosamente concepite da suscitare paura, curiosità e una strana compulsione che ci spinge ad avvicinarci e allontanarci allo stesso tempo. Apprezzando o meno il modus operandi di Sassolino: la sua installazione industriale ci pone in relazione con lo spazio catturando la nostra attenzione e coinvolgendo il nostro corpo. Inoltre, se la presenza vigorosa dell’opera qui e ora non fosse sufficiente, il suono che emette permane per quasi tutta la mostra. Essere intensi ed evidenti è l’unico o il miglior modo di fare arte? No, ma per alcuni sembra funzionare.

Francesco Bonami enfatizza indipendenza e autonomia facendo riferimento all’opera femminista di Virginia Woolf A Room of One’s Own (Una stanza tutta per sé). In questa sezione, gli artisti non seguono un unico tema, ma un’esplorazione condivisa di quella che Woolf descrive come “stanza invisibile tutta per sé”: un mondo privato tra innumerevoli altri. L’affermazione “Io sono qui” non vuole esprimere dominio, è anzi presenza che trascende genere, etnia, nazionalità o classe. Questa celebrazione dello spazio personale, glorificato rifugio interiore, diventa una dichiarazione. Qui lo spazio è psicologico, intellettuale e mentale, simile a un intimo pezzo di terra attentamente custodito, un giardino privato da coltivare. Questa sensazione pervade la sezione, dalla riflessione sull’umanità di Giulia Cenci alle personali serie di disegni a grafite su carta di Roberto Cattivelli, fino alle miniature in acquerelli e pastelli di Chiara Enzo, più in fondo nella sala.
Consentire questa espressione indefinita e non categorizzata del proprio mondo è probabilmente la risposta curatoriale più adatta alle molteplici crisi esistenziali e polarità che gli artisti affrontano oggi — divisi tra tradizione e digitale, indipendenza e strutture istituzionali, intimità ed esposizione pubblica, impegno politico e ritiro estetico, precarietà e professionalizzazione, visibilità e invisibilità, e infine desiderio di commercializzare e resistenza a farlo.

Parlando di commercializzazione, a destra dell’ingresso ci troviamo di fronte a una pratica ambigua all’interno della sezione The Unfinished Body, curata da Alessandra Troncone. In Lifeweave (2025), Emilio Vavarella promuove senza remore il suo prodotto tecnologico, supportato da un’ampia lista di filosofi — da Vilém Flusser e Byung-Chul Han a Michael Fried e Graham Harman — oltre che da istituzioni come Harvard e MIT. Siamo abituati a opere accompagnate da saggi curatoriali secondo la formula familiare di due filosofi, un sociologo e un poeta; qui, tuttavia, questo approccio tende alla parodia. La logica “showroom” risultante contrasta nettamente con ciò che Bonami intendeva celebrare nella sezione vicina, rendendo l’incontro particolarmente dissonante.
Al di là della valutazione di questo specifico concetto o prodotto, sorge una domanda più ampia: un museo—soprattutto uno con la rilevanza storica della Quadriennale d’Arte—è davvero il luogo appropriato per promuovere pratiche guidate dalle vendite?

The Unfinished Body, curata da Troncone, invita a ripensare il modo in cui oggi si narra il corpo umano e non umano, con opere che coinvolgono mito, scienza e trasformazioni sociali, coltivando prospettive complesse e stratificate. L’incompletezza viene inquadrata come uno stato produttivo: una condizione di apertura, mutazione e relazionalità. Attingendo alla ricerca genetica e agli immaginari ibridi, le opere propongono il corpo come luogo di transizione piuttosto che essenza, invitando a letture che riflettono trasformazioni sociali e tecnologiche più ampie.
Le opere di nove artisti in questa sezione—insieme alla coinvolgente pratica pittorica di Iva Lulashi, alle esplorazioni coerenti di Agnes Questionmark e al video Aaaaaaa (2025) di Valentina Furian, presentato nel buio completo senza panchina convenzionale mentre l’artista ci trasporta in una dimensione ancora più profonda e misteriosa, dove il corpo deve ritrovarsi nuovamente—si dimostrino intuitive. Allo stesso tempo, l’atmosfera orientata alla vendita stabilita nella prima sala indebolisce l’esperienza complessiva di questa sezione.
Nel mondo di oggi saturo di immagini—tra selfie, meme e un flusso infinito di contenuti social—l’arte deve confrontarsi con questo sovraccarico visivo. La sezione Il tempo delle immagini. Immagini fuori controllo? traccia l’evoluzione della fotografia in Italia dal 2000 al 2025, mostrando il lavoro di undici artisti le cui opere ci spingono a riconsiderare il valore e la responsabilità di ciò che vediamo. Emanuela Mazzonis di Pralafera ha affrontato il difficile e mirabile compito di esplorare la fotografia, medium ormai spesso ritenuto privo di cose da dire. Qui, tuttavia, la curatrice va più a fondo, espandendo il tema attraverso più dimensioni: tempo (come in News from Wonderland di Linda Fregni Nagler, 2023), autorialità (Self Portrait from Surveillance Camera di Irene Fenara, 2018–in corso) e persino sfidando le nozioni tradizionali di creazione artistica e di curatela, come dimostra il corpus di opere in continua decostruzione di Jacopo Benassi.

Che la curatrice de Il tempo delle immagini. Immagini fuori controllo? giunga o meno a conclusioni definitive è secondario. Ciò che merita davvero riconoscimento è il coraggio di affrontare un tema così complesso. Oggi la fotografia è quanto di più distante ci sia dalla mera documentazione; nel momento in cui vi si avvicina, è solo per negarla. Questa sezione interroga la realtà e si diverte a complicare tutto ciò che è implicito nell’atto di vedere. Il tempo delle immagini. Immagini fuori controllo? si conclude con un video che fa riferimento alla fine del tempo e ai buchi neri — un tentativo ambizioso, caoticamente e gioiosamente fallito, di catturare tutto ciò che sappiamo sull’immaginare.
La sezione La mia immagine è ciò da cui mi faccio rappresentare: un autoritratto. Il cibo, i gatti, la palestra, me stesso, i viaggi e ammennicoli vari, curata da Luca Massimo Barbero, esplora le complessità dell’auto-rappresentazione. Attraverso le opere di tredici artisti di tre diverse generazioni, la mostra abbraccia la tensione insita in un’opera di Lucio Fontana, dove il fronte dichiara ‘Io sono un santo’ e il retro risponde ‘Io sono una carogna’. Questa esposizione presenta un dialogo sottile tra soggettività diverse e talvolta contraddittorie, esplorando i confini fluidi della rappresentazione e dell’identità, offrendo non un semplice riflesso, ma un’esperienza più profonda: un’opportunità di vedere oltre sé stessi.

La sezione di Barbero inizia con l’autoritratto, ma devia rapidamente. Lo specchio, inteso come nell’opera Orpheus di Jean Cocteau, funziona più come una soglia che come superficie: un passaggio tra soggetto e rappresentazione. Gli artisti oscillano tra esposizione e ritiro, trattando l’identità come qualcosa da mettere in atto piuttosto che da dichiarare.
La pittura domina, ma non come linguaggio stabile; è porosa, contraddittoria, indiretta, talvolta ironica, altre volte severa. A questo punto, la prima cosa che viene in mente è l’universalità della pittura — molte opere sembrano quasi senza tempo. Matteo Faro porta questo concetto a un altro livello, usando nelle schede delle opere la dicitura “approx” — solitamente impiegata per i pittori storicizzati — per indicare i riferimenti cronologici dei suoi dipinti e disegni prodotti tra il 2015 e il 2025, a loro volta realizzati d’après opere di altri artisti, tutti ascrivibili agli anni ’30. Mentre ci muoviamo nello spazio, l’energia diventa intensa, o addirittura gioiosa, piena di ritratti e scene di genere, quasi a somigliare a un gigantesco feed che ha preso vita propria — attraverso La testa. I piedi di Roberto de Pinto, Scavenger. Self-Portrait di Marta Spagnoli e il disarmante What’s To Become of the Boy? (2025) di Emilio Gola. Non tutte le opere sono allegre, ma la maggior parte trasmette un’immagine di contentezza. Questa sezione celebra la vitalità della pittura nelle sue contraddizioni, la sua capacità di ispirare curiosità e il suo potenziale ironico.

La stanza successiva si apre con le astrazioni monocrome di Luisa Lambri, passa per le pitture acriliche di Paolo Bini ispirate agli inizi del digitale e prosegue nelle curiose esplorazioni di Gianni Caravaggio sulla nascita di un’idea. A questo si aggiunge il duo Vedovamazzei, attivo dagli anni ’90, instancabilmente paradossale e destabilizzante, che si rifiuta di offrire facili soluzioni, costringendo gli spettatori a rimanere sempre intellettualmente vigili.
In conclusione, Fantastica ci lascia sospesi tra osservazione e partecipazione, riflessione e immaginazione. Il suo titolo, che è un aggettivo e allo stesso tempo un verbo imperativo, opera su due livelli: descrizione e invito, una sorta di gentile comando a sognare, immaginare e dialogare attivamente con l’arte e il mondo che essa delinea. Questa dualità rispecchia l’esperienza stessa della mostra, dove le opere rifiutano il consumo passivo e ci invitano invece a negoziare la nostra presenza all’interno dei loro spazi.
Dobroslawa Nowak

Editato in italiano da Marianna Reggiani