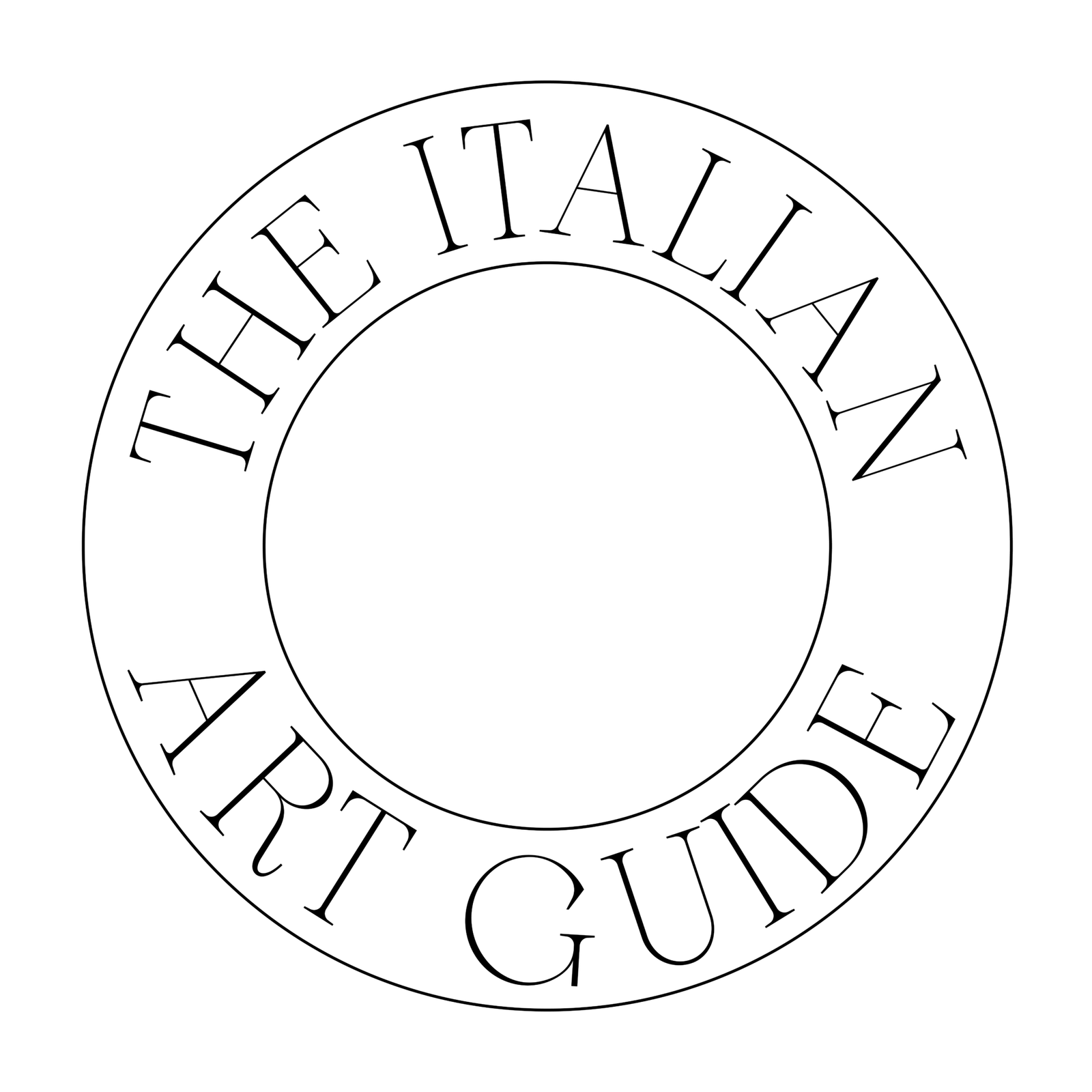Memories of Water, Memories of Air
A Venezia, artisti internazionali intonano canti per la collettività.
Intervista di Marianna Reggiani
Click here to read this interview in English
Arts Territory porta a Venezia un progetto immersivo sulle emergenze contemporanee. Con il supporto della Presidenza Polacca del Consiglio Europeo, la grande mostra a cura di Kasia Sobucka arriva in Laguna.
Se si parla di resistenza alla sopraffazione, lotta alla sopravvivenza, gestione delle proprie risorse, Venezia ha molto da insegnare. Lo sa bene il team di Arts Territory, organizzazione britannica senza scopo di lucro che ha scelto la laguna veneta come sede per il progetto immersivo curato da Kasia Sobucka presso Palazzo Contarini Polignac, uno dei più importanti edifici del primo Rinascimento.
Memories of Water, Memories of Air è un racconto visivo contemporaneo che prende le mosse da una storia collettiva fatta di perdita, rassegnazione, ritrovo, speranza. In una città che rischia di sparire sotto acque inarrestabili, spesso romanticizzata nella sua fragilità dai media e da chi dovrebbe proporre soluzioni concrete, un gruppo di artisti internazionali ha utilizzato il suono, il movimento, il video e la performance per disegnare nuove traiettorie e nuovi spazi di ritrovo e condivisione. Lo stato di emergenza, gli esodi dei migranti, le solitudini contemporanee e il sentire collettivo si intrecciano in un dialogo che permette di “creare spazio per il dolore e di illuminare le nostre sempre nuove relazioni con l’ambiente circostante”.
Monika Błaszczak, felicita, Karolina Łebek, Paweł Sakowicz,Konrad Smoleński, Rafał Zajko & Zoee, Gaetano Di Gregorio e il collettivo Fugaz propongono al pubblico le proprie letture inedite di una realtà precaria quanto controversa.

Marianna Reggiani: Il dialogo con Venezia è evidente da molteplici punti di vista: da un lato il simbolo dell’acqua, elemento purificatore ma estremamente fragile in questo momento storico; dall’altro la crisi climatica che minaccia il capoluogo veneto forse più di qualsiasi altra grande città italiana. In tal senso, Venezia è forte e combattiva – rimane vigile e attiva nella ricerca di alternative – ma allo stesso tempo è debole e precaria. Come ti sei interfacciata con la città in occasione della mostra?
Kasia Sobucka: Scegliere Venezia come sede per questo progetto ha richiesto sensibilità, umiltà e consapevolezza della natura paradossale della città, della sua grandezza e fragilità, così come della sua resistenza e vulnerabilità. Ho ritenuto essenziale non imporre una narrazione su Venezia, ma instaurare un dialogo radicato nell’ascolto e nella presenza locale.
Sin dall’inizio, la mia intenzione è stata quella di costruire un programma che fosse in armonia con la città, non solo dal punto di vista tematico ma anche relazionale. Sono andata in cerca di storie e pratiche locali, invitando artisti che vivono o che sono legati a Venezia. Il loro lavoro ha portato a intuizioni di cruciale importanza, insieme a un livello di esperienza vissuta che spesso resta invisibile ai visitatori ma che invece è profondamente radicata nel tessuto della città.
Una di queste storie è raccontata da Gaetano Di Gregorio, il cui progetto, protratto nel tempo, riflette il silenzioso e costante sforzo di conservare Venezia. Il suo lavoro affronta in modo diretto il tema dell’erosione degli edifici veneziani a causa dell’acqua salata. Gaetano ha trascorso del tempo camminando per la città, raccogliendo polvere — resti di mattoni erosi — che poi ha ricostituito in nuovi mattoni aggiungendo dell’argilla. Durante la prima giornata del programma, ha allestito una piccola postazione sulla quale lavorare per portare avanti questo processo in tempo reale, trasformando così la perdita in rigenerazione.


Questo gesto, di natura quasi meditativa, è profondamente simbolico. Venezia è una città che si sgretola e si ricostruisce continuamente, un organismo vivente la cui sopravvivenza dipende da cura e manutenzione costanti. L’azione di Gaetano di ricavare nuovi mattoni dalle rovine, con tracce di acqua salata ancora incorporate nella materia, cattura questo aspetto in modo magnifico. Il ricordo del sale, dell’erosione e dell’evaporazione viene trasformato in qualcosa di nuovo. Il suo progetto si rivolge a una cultura dell’attenzione, della conservazione, di una sorta di resistenza silenziosa radicata nella cura, un cuci-scuci veneziano: i rituali di ricostruzione quotidiana che definiscono la vita in questa città.
Questa attenzione prosegue nel lavoro del collettivo locale Fugaz, che il giorno successivo ha offerto un’esperienza sensoriale e gustativa. Il loro menù si basa su ingredienti locali e sull’elemento dell’acqua, creando una narrazione multisensoriale radicata nell’ecologia lagunare. Attraverso il gusto e il profumo, il loro lavoro amplia l’idea di arte effimera e la trasporta su un altro registro, in cui memoria e resilienza vengono espresse non solo attraverso la vista e il suono, ma anche attraverso il sapore, il tatto e l’incontro collettivo.
Curando il programma, il mio intento non è stato quello di trattare Venezia come uno sfondo o una metafora, ma di considerarla una partecipante. Venezia ci insegna che la resilienza non è né rumorosa né grandiosa. È frutto di un accumulo, costruita da piccoli gesti di attenzione e perseveranza. È questo lo spirito alla base del progetto.

M.R.: La mostra affronta temi di enorme importanza e complessità nella società contemporanea, dalla crisi ecologica al viaggio dei migranti fino alla riflessione sulle nostre solitudini individuali. Hai sentito una qualche forma di responsabilità nel trattare argomenti che toccano, in varia misura e in modi diversi, così tante persone?
K.S.: Quando si lavora con tematiche così profondamente radicate e di vasta portata come il collasso ecologico, le migrazioni e il lutto individuale e collettivo, bisogna ricordare che non si tratta di concetti astratti, ma di realtà autentiche che regolano la vita, la storia e il futuro delle persone. In qualità di curatrice e operatrice culturale, ritengo che il nostro ruolo non sia solo quello di presentare le opere, ma anche di riservare uno spazio per la complessità, il dolore e la consapevolezza. Nel curare Memories of Water, Memories of Air, ho voluto creare una struttura che rendesse onore al tema con la sensibilità che merita, invitando il pubblico in uno spazio di riflessione condivisa.
Non ho affrontato questi temi con l’intento di fornire risposte o soluzioni. Al contrario, il mio obiettivo era creare uno spazio in cui porre domande difficili e necessarie, attraverso il linguaggio dell’effimero. Di fronte all’instabilità ecologica e allo sgretolamento sociale, l’effimero e l’intangibile — il respiro, il gesto, il suono — diventano potenti involucri per ricordare ciò che è andato perduto e immaginare ciò che potrebbe ancora essere recuperato.
Mi ha particolarmente colpito osservare come l’effimero offra una strada per esplorare non solo la fragilità del nostro ambiente, ma anche la resilienza legata alla memoria culturale e al sapere ancestrale. Partendo dai rituali dell’acqua caratteristici dell’Est Europa, in particolare quelli della minoranza Łemko, questo progetto mette in evidenza voci e pratiche spesso escluse dai discorsi dominanti in merito al clima e alle migrazioni. Offre un’altra via per conoscere, ovvero attraverso il corpo, il rito, l’esperienza sensoriale.
Questa presa di responsabilità ha poi influenzato anche il modo in cui ho presentato questi temi. Ho cercato attentamente di evitare la spettacolarizzazione o la semplificazione. Al contrario, il programma è stato pensato all’insegna della compassione, permettendo a ogni opera di risuonare all’interno del proprio contesto e invitando il pubblico a portare le proprie storie e i propri paesaggi emotivi.

Memories of Water, Memories of Air è stato progettato anche come un laboratorio vivente, uno spazio per testare quanto l’arte possa essere luogo di trasformazione, ricordo e reimmaginazione. In un’epoca in cui gli elementi che ci tengono in vita — aria, acqua, terra — sono sempre più minacciati, credo sia più importante che mai domandarsi quale ruolo possa rivestire l’arte nel nutrire la memoria e la resilienza.
Per curare il programma è stato necessario ascoltare profondamente le storie, gli artisti, la terra e Venezia stessa. Questo ha significato assecondare le contraddizioni — tra bellezza e perdita, tra celebrazione e lutto — e confidare nel fatto che l’effimero possa essere una fonte di connessione profonda.
M.R.: La mostra si pone una domanda specifica, come si legge nel comunicato stampa: “Possono le arti effimere creare spazi di memoria e resilienza in tempi di crisi e instabilità?”. Come curatrice, cosa pensi che renda le arti effimere più inclini, rispetto ad esempio alle arti figurative, a rispondere a queste lotte collettive?
K.S.: Credo che le arti effimere siano particolarmente adatte a rispondere alle lotte collettive proprio grazie alla loro natura provvisoria. A differenza delle arti figurative o degli oggetti d’arte, che spesso affermano una presenza e un’autorità definita, le pratiche effimere invitano a un rapporto con il pubblico più fluido, autentico e partecipativo. Non operano attraverso la stabilità, ma attraverso la presenza.
Nel corso della storia, la cultura è stata trasmessa non solo attraverso monumenti e immagini, ma anche attraverso pratiche intangibili, come canti, storie, riti e gesti condivisi. Queste attività effimere hanno sempre avuto un ruolo centrale nel plasmare l’identità e la memoria, soprattutto all’interno di comunità emarginate o diasporiche, in cui le storie ufficiali possono escludere o cancellare determinate voci. In tal senso, l’arte effimera si sposa bene con le pratiche culturali di resilienza. Si crea quella che definirei una membrana, porosa e viva, della memoria: stratificata, sensoriale e collettiva.

Nel curare questo programma, ho voluto esplorare come i media effimeri — quali il suono, il movimento, il gusto o il tatto — possano offrire un linguaggio della memoria alternativo. Questi media sono potenti proprio perché coinvolgono più sensi. La loro transitorietà li rende preziosi: accadono una sola volta, in un momento specifico, in uno spazio condiviso. Questa fragilità invita all’attenzione, chiede al pubblico di essere presente, di essere testimone e di condividere lo spazio con gli altri. Paradossalmente, la natura fugace di queste esperienze le rende resistenti nella mente e nel corpo, impresse nella memoria proprio perché non possono mai ripresentarsi allo stesso modo.
C’è anche un’etica dell’effimero: non impone un significato, piuttosto lascia spazio all’interpretazione. Permette a ognuno di incontrare l’opera alle proprie condizioni, attraverso l’esperienza personale. Nei momenti di instabilità, quando le narrazioni ormai consolidate si sgretolano o risultano inadatte, tale apertura può rivelarsi estremamente potente. Essa offre un modello che non finge di avere tutte le risposte, ma che crea uno spazio per provare emozioni, ricordare e immaginare insieme.
Quindi sì, credo che le arti effimere possano sostenere e persino generare resilienza, non malgrado la loro fragilità, ma proprio grazie ad essa. La loro capacità di fondersi con i sensi, di annullare i confini tra artista e pubblico, tra privato e collettivo, le rende una fonte inestimabile di testimonianza culturale ed emotiva.
M.R.: Alcuni artisti in mostra parlano delle proprie storie personali. Ad esempio, nell’opera Sanare di Karolina Łebek, l’artista esplora i propri ricordi, il trauma generazionale e la storia della sua famiglia. Allo stesso tempo, il suo lavoro racconta un evento della storia collettiva, la deportazione della minoranza etnica di Łemko, culminata nell’Operazione Vistola (1947). Hai trovato difficile spostarti tra queste due dimensioni, privata e collettiva? Queste prospettive parallele su cui si basa la storia di Karolina hanno influenzato il tuo dialogo con lei?
K.S.: Lavorare con Karolina Łebek su Sanare è stata un’esperienza profondamente stimolante. Il lavoro era stato originariamente commissionato da Arts Territory come parte di un progetto che ho curato diversi anni fa, The Illusion of Return. Il progetto stesso è nato come reazione al clima post-Brexit nel Regno Unito, in particolare all’ostilità dello slogan “Go back home”, che era diventato un simbolo di esclusione. Come risposta, ho invitato gli artisti che avevano scelto di fare del Regno Unito lo loro nuova casa, per riflettere sull’idea di ritorno, inteso sia come viaggio fisico sia come confronto con le narrazioni ereditate, i miti e i paesaggi emotivi spesso complessi delle loro terre d’origine.

Karolina è stata una degli artisti che sono “tornati” a casa per una breve residenza. Il suo approccio, radicato nella memoria personale e nelle esperienze vissute dalla sua famiglia, ha aperto uno spazio fondamentale all’interno di questo progetto. Sanare si muove delicatamente tra il terreno intimo del trauma generazionale e una storia collettiva più ampia, spesso trascurata: lo sfollamento della popolazione Łemko durante l’Operazione Vistola nel 1947. Muoversi tra queste due dimensioni, quella privata e quella collettiva, non è stato difficile, anzi si è rivelato necessario. Nel lavoro di Karolina, il personale non è mai fine a sé stesso, ma è il tramite per rompere il silenzio storico e per riattivare e riumanizzare una memoria collettiva dimenticata. Questo progetto è stato per me un’occasione per imparare. Cresciuta in Polonia, non sono mai stata pienamente consapevole delle diverse componenti etniche e culturali del Paese; piccole comunità come quella dei Łemkos sono state invisibilizzate dalle narrazioni dominanti di portata nazionale. È attraverso progetti come Sanare che ho iniziato a capire quanto sia davvero complesso, vario e stratificato il tessuto sociale polacco. La storia dell’Operazione Vistola non è solo un capitolo della storia, è un’esperienza di esilio, rifiuto e ricostruzione dell’identità che continua a plasmare le comunità e gli individui ancora oggi.
L’artista potrà meglio rispondere alla domanda su come questa storia influenzi esplicitamente il suo vocabolario artistico. Tuttavia, da una prospettiva curatoriale, posso dire che la sua capacità di trasmettere sia il dolore personale che il trauma collettivo attraverso un unico gesto crea un dialogo potente, non solo tra l’artista e il pubblico, ma anche tra passato e presente, visibilità e cancellazione. Questo aspetto ha plasmato profondamente le nostre conversazioni e mi ha confermato quanto sia importante dare spazio, nell’arte contemporanea, a queste narrazioni sfumate e stratificate.
M.R.: Nell’opera Waiting Room di Konrad Smoleński, l’artista ha incorporato le fotografie dell’artista Shamal Husamalddin Hassan, che documentano le famiglie dei migranti curdi scomparsi durante il viaggio verso l’Europa.
La seconda parte dell’opera è un’installazione composta da cellulari che contengono frammenti di storie di persone scomparse (immagini, messaggi e estratti dai media).
Infine, c’è il video che l’artista ha registrato durante la permanenza di due settimane nelle città del Kurdistan, da dove la maggior parte dei migranti ha tentato di raggiungere l’Europa: il video comprende, tra le altre cose, una prospettiva dall’interno di una barca che fluttua sulle acque aperte.
Konrad Smoleński affronta quindi il difficile tema della migrazione in un modo che sembra essere lontano dalla romanticizzazione, che spesso crea ulteriore distanza e ostacola la comprensione del problema.
C’è stata un’attenzione specifica nella creazione e nell’allestimento di quest’opera per evitare il rischio di romanticizzazione?
K.S.: Fin dall’inizio, lavorando con Konrad per presentare Waiting Room, abbiamo capito che non si trattava di una narrazione storica chiusa, ma di un trauma vivo e attuale che continua a definire famiglie e comunità. Non si tratta di temi astratti, ma di esperienze vissute che hanno un profondo peso emotivo e politico. La nostra responsabilità è stata quella di dare spazio a tale complessità senza appiattirla nella spettacolarizzazione o nel sentimentalismo.
Il progetto nel suo complesso si chiede come le forme effimere possano diventare contenitori di memoria, connessione e cura. In Waiting Room, questa domanda si fa particolarmente carica di significato. È un lavoro plasmato dall’assenza, dal silenzio, dalle tracce. Piuttosto che imporre un’interpretazione o una direzione emotiva, abbiamo voluto creare uno spazio in cui gli spettatori potessero riflettere su queste storie secondo le proprie inclinazioni.
La collaborazione tra Konrad Smoleński e Shamal Husamalddin Hassan è stata fondamentale per costruire il lavoro su una rappresentazione etica. Shamal è un artista curdo che ha documentato le storie delle famiglie scomparse mentre erano in viaggio verso l’Europa, alla ricerca della vita migliore che avevano immaginato. Provenivano principalmente dalla città di Rania, nel Kurdistan iracheno, una regione da cui emigra un numero di giovani che cresce ogni anno di più.

Il lavoro di Shamal si basa su anni di silenziosa dedizione alla sua comunità. Il film di Konrad è stato creato durante lo sviluppo di una mostra congiunta, tenutasi durante una visita di due settimane in Kurdistan. Il film integra il lavoro di Shamal con un linguaggio visivo poetico ed effimero che invita a un coinvolgimento emotivo senza imporre alcuna autorità. Si tratta di un attento gioco di equilibri che rivolge un’attenzione etica verso il modo di raccontare queste storie.
Sostanzialmente, l’obiettivo era creare uno spazio in cui gli spettatori potessero confrontarsi con queste storie secondo le proprie preferenze. Non volevamo imporre alle persone cosa provare o offrire risposte semplici. Abbiamo invece cercato di onorare la complessità e la dignità delle storie che raccontiamo e di invitare alla riflessione. In fin dei conti, il grado di connessione con l’opera è una scelta personale, e lo spazio è stato modellato con grande cura per consentire tale connessione. Abbiamo sperato che l’esperienza favorisse una comprensione della migrazione e del concetto di perdita che fosse più vera e umana, nel momento in cui lo spettatore avesse scelto di farsi coinvolgere.
Questo aspetto è stato fortemente percepito a Venezia, dove il video è stato proiettato dall’interno di una piccola barca che fluttuava sull’acqua, un’esperienza pensata con Hamed Hamadi, migrante giunto a Venezia dall’Afghanistan. La bellezza della laguna veneziana, il calore della luce e il dondolio della barca hanno creato una forte tensione con il contenuto dell’opera. Questo scontro tra serenità e dolore, tra Venezia e la violenza silenziosa della scomparsa, ha lasciato molti spettatori visibilmente scossi.

Spero che l’ambientazione non abbia diluito il messaggio dell’opera, ma che lo abbia reso più intenso. Il mare, sia come storica rotta di migrazione sia come luogo di innumerevoli scomparse, è stato parte dell’esperienza. Questa dimensione fisica, sensoriale e tangibile ha permesso al pubblico di entrare in contatto con l’opera in modo estremamente personale e, per molti, profondamente emotivo. Non abbiamo detto al pubblico cosa provare, ma lo abbiamo invitato a soffermarsi su ciò che non può essere pienamente compreso o risolto. E in questo invito abbiamo sperato di onorare la dignità delle storie che stiamo ancora imparando a portare con noi.
M.R.: Ho trovato molto interessante la duplicità del progetto, descritto come “sia una lamento che una chiamata all’azione”, per cui c’è dolore ma anche speranza che qualcosa possa ancora cambiare. A volte il lamento, a differenza della protesta, può portare a un diverso tipo di coinvolgimento emotivo — più profondo e sentito — che tocca le parti più profonde di noi, altrimenti nascoste dalla rabbia e dal risentimento. Mi chiedo quindi in che misura queste emozioni siano presenti nel progetto e se siano in contrasto tra loro oppure coesistano.
K.S.: Grazie per la domanda così attenta e perspicace. La duplicità a cui ti riferisci è infatti il cuore di Memories of Water, Memories of Air. Sin dalla sua prima ideazione, ho cercato di esplorare quel terreno emotivo in cui il lutto e la speranza non si annullano a vicenda, ma coesistono. Credo infatti che essi debbano coesistere se vogliamo rispondere in modo significativo ai vari livelli delle crisi che affrontiamo: ecologiche, sociali ed esistenziali.
Il lamento, come suggerisci, offre un livello di coinvolgimento emotivo che spesso manca alle forme più dirette di protesta. Lascia spazio al dolore, alla vulnerabilità e alla lentezza, qualità che raramente vengono concesse all’urgenza dell’attivismo o al fragore del discorso pubblico. Con questo progetto abbiamo deliberatamente incluso queste emozioni. Abbiamo creato uno spazio in cui la fragilità potesse essere onorata e gli artisti potessero rispondere non solo intellettualmente, ma anche attraverso il corpo e lo spirito, ai temi della perdita, della diaspora e dell’incertezza ecologica.

Allo stesso tempo, non credo che il lamento sia un atto passivo. È diverso dalla rassegnazione. Può generare cose nuove. Molte opere in programma sono ancorate a pratiche ancestrali di lutto che portano in sé anche il seme della resilienza. Per esempio, l’opera di Karolina Łebek, basata su un trauma personale e generazionale, diventa un atto di guarigione, non solo per lei ma per la comunità. Konrad Smoleński non offre conclusioni facili, ma invita a una forma di empatia silenziosa e duratura. Il processo di fabbricazione dei mattoni di Gaetano di Gregorio, che utilizza la polvere dell’architettura veneziana erosa, trasforma il degrado in potenziale, una metafora materica del rinnovamento.
Per tornare alla tua domanda, non credo che il lamento e la speranza siano in contrasto qui. Non sono due opposti da riconciliare, ma correnti emotive intrecciate che si alimentano a vicenda. Piangere ciò che si è perso — sia una cultura, una casa o l’accesso all’acqua potabile — è anche un modo per riaffermarne il valore, per insistere sulla sua conservazione. In tal senso, il lamento si fa atto politico, fondato sulla cura piuttosto che sullo scontro.
Questo progetto vuole offrire uno spazio in cui gli spettatori possano confrontarsi con queste contraddizioni emotive e magari iniziare a muoversi all’interno di esse. Ci si chiede: cosa significa ricordare insieme, piangere collettivamente e tuttavia immaginare un futuro diverso? È in questa interazione tra lutto e creazione di significato, fragilità e resistenza, che credo che Memories of Water, Memories of Air trovi la sua voce più onesta ed emozionante.

*estratto dal comunicato stampa
Tradotto in Italiano da Marianna Reggiani
Memories of Water, Memories of Air
Monika Błaszczak, felicita, Karolina Łebek, Paweł Sakowicz, Konrad Smoleński, Rafał Zajko & Zoee, Gaetano Di Gregorio e Fugaz
A cura di Kasia Sobucka
Organizzato da Arts Territory e Ditto Foundation
Con il supporto di Istituto Polacco di Roma
Co-finanziato dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia tramite il Fondo per la Promozione della Cultura.
Evento culturale della Presidenza Polacca del Consiglio Europeo
Palazzo Contarini Polignac, Dorsoduro, 874, 30123, Venezia
27-28.06.2025